
Dai presidenti padroni ai fondi globali: chi comanda oggi il calcio europeo? - M&A - Mergers & Acquisitions
Nel calcio europeo è in atto una trasformazione storica delle strutture proprietarie dei club. Se un tempo i club più prestigiosi erano spesso controllati da famiglie locali, imprenditori-mecenati o direttamente dai propri tifosi (come nel caso delle società sportive gestite dai soci), oggi la scena vede l’ascesa di investitori globali: fondi di private equity, sovereign wealth fund legati a Stati esteri, holding internazionali e multi-club ownership groups. Nelle cinque maggiori leghe europee (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) i capitali stranieri sono diventati protagonisti, portando nuove risorse finanziarie ma anche una crescente complessità nei modelli di governance. Emblematico è il caso dell’Atlético de Madrid, club che per finanziare un ambizioso progetto immobiliare da 800 milioni di euro ha aperto il capitale a investitori istituzionali: prima il fondo statunitense Ares Management (entrato nel 2021 con circa il 34% della holding proprietaria del club) e ora l’interesse del colosso Apollo Global Management. Ma come si è arrivati a questo punto? E quali accordi parasociali e strutture finanziarie stanno plasmando la nuova mappa dei club ownership in Europa?
CAPITALI STRANIERI NELLE TOP5 LEGHE EUROPEE
La Premier League inglese è stata apripista nell’attrarre proprietari internazionali sin dai primi anni 2000 (basti pensare all’acquisto del Chelsea da parte del magnate russo Abramovich nel 2003). Oggi ben 9 club su 20 in Premier League hanno azionisti di maggioranza statunitensi, ai quali si aggiungono proprietà da Medio Oriente e altre parti del mondo. Ad esempio, il Manchester City è controllato dal 2008 dallo sceicco Mansour di Abu Dhabi e dal suo fondo sovrano, mentre il Newcastle United dal 2021 fa capo a un consorzio guidato dal fondo sovrano saudita (PIF), entrato con l’80% delle quote societarie. La presenza americana è forte anche in club di vertice come il Liverpool (Fenway Sports Group) e il Manchester United (famiglia Glazer), mentre recentemente il Chelsea è passato sotto il controllo di un consorzio guidato dall’imprenditore USA Todd Boehly. Questa “americanizzazione” della Premier riflette l’appeal globale del campionato inglese, il più ricco per ricavi televisivi e sponsor.
Anche in Serie A si osserva un trend simile, ma di epoca più recente. Tradizionalmente dominata da dinastie italiane (Agnelli alla Juventus, Moratti all’Inter, Berlusconi al Milan), la Serie A ha visto nell’ultimo decennio un ingresso massiccio di capitali nordamericani. Attualmente si contano 9 club su 20 con proprietà di investitori USA o canadesi. Tra questi figurano alcuni storici come l’AC Milan (acquisito nel 2022 dal fondo americano RedBird per 1,2 miliardi di euro) e l’AS Roma (dall’estate 2020 controllata da Dan Friedkin, tycoon texano dell’automotive). Anche realtà di provincia sono finite in orbita USA: il Bologna (famiglia Saputo), la Fiorentina (Rocco Commisso), il Genoa (777 Partners) e altre. Le ragioni di questo interesse? In parte il costo di acquisizione più contenuto rispetto ai top club inglesi, unito al potenziale di crescita del calcio italiano dopo anni difficili. Come evidenziato dagli analisti, comprare un club di Serie A può risultare “economico” in confronto ad altre franchigie sportive: ad esempio, l’AC Milan è costato circa 1,2 miliardi di euro, mentre una squadra NFL come i Dallas Cowboys vale attorno ai 10 miliardi di dollari. Inoltre, la struttura proprietaria di altre leghe offre meno opportunità: in Spagna i club più blasonati sono associazioni sportive, in Germania vige la regola del 50+1 che limita il controllo agli investitori esterni. L’Italia, priva di questi vincoli, si è aperta ai finanziatori esteri in cerca di asset sottovalutati da rilanciare.
Situazione diversa in Spagna e Germania, dove i modelli tradizionali resistono in parte all’ondata di acquisizioni straniere. In Spagna quattro club (Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Osasuna) mantengono lo status di società sportive di proprietà dei soci, con un modello associativo che di fatto impedisce l’ingresso di azionisti privati. Ciò non ha però escluso investimenti esterni nel resto della Liga: il caso Atlético Madrid lo dimostra, così come l’ingresso nel capitale del Siviglia di investitori statunitensi (fondi come 777 Partners) o la proprietà del Valencia in mano al magnate singaporiano Peter Lim. Inoltre, dal 2021 LaLiga ha lanciato insieme al fondo CVC Capital Partners l’operazione “LaLiga Impulso”, un’iniezione di 2 miliardi di euro nelle casse dei club in cambio di una percentuale dei diritti TV per i prossimi 50 anni. Molti club – Atlético incluso – hanno aderito ricevendo decine di milioni (circa 120 milioni di euro per l’Atlético), anche se i due giganti Real e Barça si sono opposti (e infatti non partecipano all’accordo). In Germania, invece, la regola del 50+1 impone che almeno il 50% + 1 azione di ogni club appartenga ai tifosi-soci, limitando per legge il controllo da parte di investitori privati. Solo poche eccezioni storiche hanno bypassato questa norma – come il Bayer Leverkusen (controllato da Bayer) o il Wolfsburg (Volkswagen) – oppure l’hanno aggirata tramite stratagemmi (il caso Red Bull Lipsia, formalmente un club con soci “selezionati”). Questa struttura ha finora tenuto lontano i fondi internazionali, sebbene alcuni abbiano acquisito quote di minoranza (ad esempio, il 25% del Hertha Berlino è stato ceduto al fondo americano 777 Partners nel 2022). In Francia, infine, non esistono regole paragonabili al modello tedesco, e infatti diversi club di Ligue 1 hanno proprietà straniere: il Paris Saint-Germain è posseduto dal 2011 dal fondo sovrano del Qatar (via Qatar Sports Investments) – investimento che ha trasformato il PSG in una potenza europea –; l’Olympique Marsiglia è di proprietà americana (Frank McCourt) dal 2016; il Olympique Lione è passato nel 2022 sotto il controllo della holding statunitense Eagle Football di John Textor. Non mancano investitori britannici (il miliardario Jim Ratcliffe ha acquistato il Nizza) e altri. Tuttavia, la Ligue 1 ha sofferto negli ultimi anni di problemi sui diritti televisivi e una minore attrattiva commerciale rispetto ad altre leghe, fattori che hanno reso meno immediato il “boom” di acquisizioni rispetto a Italia e Inghilterra.
PATTI PARASOCIALI E SOCI “DOMINANTI” NEI CLUB
L’ingresso di fondi di investimento e nuovi azionisti nei club calcistici europei avviene spesso attraverso accordi di governance complessi, volti a garantire determinate tutele o diritti speciali. Questi patti parasociali possono di fatto creare dei “soci dominanti” anche senza il controllo della maggioranza assoluta del capitale. Il caso dell’Atlético de Madrid è illuminante: nel 2021, per rafforzare patrimonialmente il club durante la pandemia, il fondo Ares Management ha sottoscritto un aumento di capitale di circa 182 milioni di euro, ottenendo il 33,96% della nuova holding Atlético HoldCo. Miguel Ángel Gil Marín – figlio dello storico presidente Jesús Gil – restava socio di maggioranza relativa della holding (con circa il 50-51%), mentre il restante capitale era detenuto dal presidente Enrique Cerezo (~15%) e da investitori diretti come la Quantum Pacific di Idan Ofer (imprenditore israeliano con ~27% del club). L’ingresso di Ares è avvenuto con un accordo parasociale che protegge il fondo americano e gli conferisce un ruolo chiave: Ares infatti si è riservato un diritto di tanteo (diritto di prelazione) sulle azioni di Gil Marín. In pratica, se Gil volesse vendere la propria quota di maggioranza, dovrebbe notificare l’offerta ricevuta ad Ares, il quale avrebbe la facoltà di rilevare lui stesso le azioni allo stesso prezzo offerto dal terzo acquirente, assicurandosi così il controllo del club. Questo meccanismo blinda la posizione di Ares e gli consente, di fatto, di bloccare l’ingresso di nuovi soci non graditi semplicemente pareggiando le loro offerte. Non sorprende dunque che, quando nelle scorse settimane Apollo Global Management ha manifestato interesse a investire nell’Atlético (attraverso un aumento di capitale su una valutazione di 2,5 miliardi di euro), Ares abbia fatto valere il proprio ruolo di gatekeeper: forte del tanteo, può eguagliare l’eventuale offerta di Apollo e incrementare la propria partecipazione, impedendo all’altro fondo di “entrare” nel capitale di Atlético HoldCo. In definitiva, pur essendo un socio di minoranza, Ares controlla il portone d’accesso del club grazie a un accordo contrattuale – uno strumento sempre più diffuso nel calcio-business.
Un’altra modalità con cui gli investitori uscenti mantengono influenza è il vendor loan, ossia un finanziamento concesso dal venditore all’acquirente in fase di cessione del club. Questo è avvenuto nell’operazione di vendita dell’AC Milan nel 2022: il fondo Elliott Management, dopo aver rilevato il Milan nel 2018 (escutendo il pegno sulle azioni a garanzia di un prestito non rimborsato dall’allora proprietario cinese Yonghong Li), ha deciso di rivendere la società al nuovo investitore RedBird Capital. La transazione da 1,2 miliardi di euro non è però avvenuta completamente cash: circa la metà della cifra, 550 milioni di euro, è stata lasciata da Elliott a RedBird sotto forma di prestito a 3 anni (tasso d’interesse 7%), il cosiddetto “vendor loan”. In altre parole, Elliott ha fatto da banca al compratore, mantenendo un credito significativo garantito da un pegno sulle azioni del Milan (in caso di mancato rimborso, Elliott potrebbe riprendersi il controllo del club). Questo accordo finanziario ha permesso a Elliott di conservare un ruolo di fatto nella gestione: il fondo di Paul Singer ha ottenuto tre posti su dieci nel Consiglio di Amministrazione del Milan post-vendita, occupati da figure chiave vicine a Elliott (Gordon Singer – figlio di Paul – oltre a Giorgio Furlani e Stefano Cocirio, divenuti rispettivamente AD e CFO del Milan). Inoltre, il presidente del club Paolo Scaroni, nominato da Elliott nel 2018, è rimasto in carica anche con RedBird, a ulteriore garanzia di continuità. Formalmente Elliott oggi è un creditore “puro” e non figura nell’azionariato, ma fino al rimborso completo del prestito (dicembre 2025) esercita un’influenza non trascurabile sulle scelte strategiche della società rossonera. Situazioni analoghe si sono viste altrove: l’Inter ad esempio ha contratto nel 2021 un maxi-finanziamento da 275 milioni con il fondo Oaktree Capital (tasso ~12%), dando in pegno la quota di maggioranza del club detenuta da Suning. Quando nel maggio 2024 la proprietà cinese non ha ripagato il debito entro la scadenza, Oaktree ha immediatamente escusso il pegno e rilevato il controllo dell’Inter – ricalcando quanto fece Elliott col Milan qualche anno prima. Sono tutti esempi di come, attraverso accordi finanziari e parasociali, un investitore possa influire sulla governance di un club ben oltre la percentuale di azioni possedute.
IL MODELLO MULTI-CLUB: IL CASO CITY FOOTBALL GROUP
Un capitolo a parte merita il fenomeno delle multiplie proprietà di club (multi-club ownership), un modello innovativo emerso nell’ultimo decennio. Invece di acquisire un singolo club, alcuni investitori hanno costruito portafogli di società calcistiche in diverse nazioni, creando sinergie tecniche e commerciali su scala globale. Il paradigma di questa strategia è la City Football Group (CFG), il conglomerato che fa capo agli emiri di Abu Dhabi con al centro il Manchester City. Fondata nel 2013, la City Football Group è oggi il maggiore operatore privato multi-club al mondo, con partecipazioni totali o parziali in 13 squadre di calcio nei cinque continenti. Il cuore del gruppo è il Manchester City, acquistato dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan nel 2008 per circa £210 milioni. Dal 2021, l’assetto proprietario di CFG vede Mansour detenere circa l’81% tramite il suo veicolo Abu Dhabi United Group, affiancato dal fondo USA Silver Lake (18% circa) e da soci cinesi (China Media Capital e CITIC Capital) per la quota residua. Nel portafoglio di City Football Group figurano club di primo piano nei rispettivi mercati: il New York City FC negli USA (fondato nel 2015 assieme ai New York Yankees, con CFG all’80%), il Melbourne City in Australia (100% di proprietà CFG), il Yokohama F. Marinos in Giappone (dove CFG ha una quota di minoranza accanto a Nissan), il Girona FC in Spagna (44,3%, in partnership con un gruppo locale legato alla famiglia Guardiola), e poi ancora il Montevideo City Torque in Uruguay, il Mumbai City FC in India, il Lommel SK in Belgio, il ESTAC Troyes in Francia, fino ad arrivare al Palermo FC in Italia (acquistato all’80% nel 2022 e poi salito al 94,5%) e al recente ingresso nel calcio brasiliano con il Bahia (90% delle quote rilevate nel 2023). L’idea alla base del modello multi-club è creare una rete globale di squadre che condividono conoscenze, risorse e talenti: i giocatori possono essere trasferiti o prestati all’interno del network per accelerarne la crescita (ad esempio, fu notorio il “giro” di David Villa, ingaggiato dal New York City e subito girato in prestito al Melbourne City nel 2014). Anche a livello di brand e sponsorizzazioni, la piattaforma CFG consente economie di scala e accordi centralizzati, massimizzando i ricavi commerciali. Dal punto di vista sportivo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il Manchester City, fiore all’occhiello del gruppo, ha vinto 7 Premier League negli ultimi 12 anni e nel 2023 ha conquistato la prima UEFA Champions League della sua storia, coronando un progetto tecnico ambizioso. Il modello City Football Group – pur con qualche critica sul fronte della “calcio globalizzato” – è diventato un riferimento nel settore, al punto che altri investitori stanno replicando strategie simili. Basti pensare al gruppo Red Bull, pioniere con le sue squadre omonime in Austria (Salzburg), Germania (RB Leipzig), USA (New York Red Bulls) e Brasile (Bragantino); oppure a holding recenti come 777 Partners, che ha messo insieme partecipazioni in club storici come Standard Liegi, Hertha Berlino, il già citato Genoa e perfino il Siviglia (di cui ha rilevato circa il 15%); o ancora Eagle Football di Textor, che collega Olympique Lione, Crystal Palace, Botafogo (Brasile) e RWD Molenbeek (Belgio) sotto una visione comune. City Football Group però rimane l’esempio più emblematico e strutturato di multi-club empire: un “family office calcistico globale” che va oltre i confini nazionali e anticipa forse il futuro del calcio come industria globale integrata.
L’evoluzione delle proprietà calcistiche nelle principali leghe europee riflette la crescente convergenza tra sport e finanza internazionale. I club di vertice sono diventati asset di investimento globali, appetibili per miliardari, fondi e persino Stati, attratti sia dal potenziale di ritorno economico sia dalla visibilità planetaria che il calcio garantisce. Questo mutamento ha portato benefici in termini di capitali freschi, professionalizzazione delle gestioni e sviluppo di infrastrutture (stadi moderni, centri sportivi all’avanguardia). Tuttavia, pone anche nuove sfide: dalla tutela dell’identità e tradizione sportiva locale, alla garanzia di concorrenza leale (si pensi alle questioni di fair play finanziario o ai potenziali conflitti d’interesse nel modello multi-club, che UEFA monitora imponendo ad esempio trust ciechi sulle partecipazioni incrociate). Inoltre, con l’ingresso di sofisticati accordi parasociali e strumenti finanziari, la governance dei club si fa più complessa e talvolta opaca per i tifosi. Il calcio europeo del XXI secolo assomiglia sempre più a un mercato globale, in cui la partita si gioca non solo sul campo ma anche nei consigli di amministrazione e nei tavoli di negoziazione finanziaria. Per gli appassionati e gli addetti ai lavori, comprenderne le dinamiche proprietarie è fondamentale per capire in che direzione andrà lo sport più amato del mondo. E alla luce delle tendenze attuali – dall’espansione dei multi-club ai fondi che dettano condizioni – una cosa appare certa: la geografia del potere nel calcio continuerà a ridisegnarsi, sospesa tra tradizione sportiva e logiche di corporate finance.
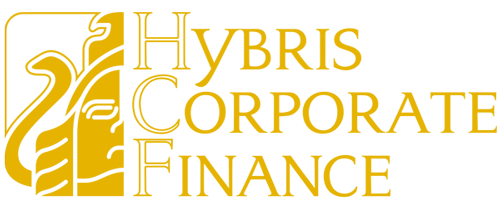
 News
News